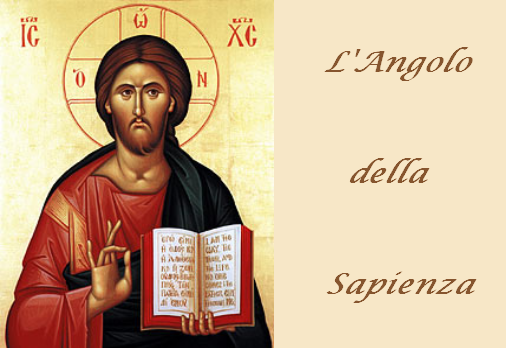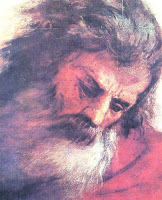martedì 22 marzo 2011
La Città di Dio - X parte
Riprendiamo la lettura dell'opera di Sant'Agostino nota come "La città di Dio". Il pensiero odierno è tutto incentrato sulla difesa della cristianità in mezzo ad un popolo consacrato a dei inesistenti e profani. Ciò che a noi più interessa è vedere come il pensiero agostiniano può facilmente esser trasfuso ai giorni nostri: basta sostituire i cultori di dei pagani con i cultori dell'ateismo e di ogni forma di allontanamento da Dio. Anche oggi, infatti, ciò che spinge l'uomo a non credere nel messaggio evangelico è pur sempre la ricerca del benessere, del potere, della ricchezza e del piacere egoistico. Fintantoché l'uomo sarà attirato da questi mali, non potrà mai vedere Dio né il vero significato della vita terrena che altro non è se un pellegrinaggio di preparazione per l'eternità di cui Gesù ci ha resi partecipi:
29. Dunque tutta la servitù del sommo e vero Dio ha il suo conforto non menzognero e non fondato sulla speranza di cose incerte o caduche; ha anche la stessa vita terrena che non si deve affatto avere in uggia perché in essa la servitù stessa è educata alla vita eterna. Come esule inoltre usa senza rendersene schiava dei beni terreni ed è o provata o purificata dai mali. Ma alcuni insultano la sua moralità e le dicono, quando eventualmente incorre in determinate sciagure temporali: Dov'è il tuo Dio? 88. Dicano loro piuttosto dove sono i loro dèi quando subiscono tali sventure giacché li onorano e si affaticano a farli onorare proprio per evitarle. Essa può rispondere: "Il mio Dio è presente in ogni luogo, tutto in ogni luogo, non limitato nello spazio perché può esser presente senza rivelarsi, assente senza muoversi. Quando mi sprona con le avversità, o soppesa i meriti o punisce i peccati e mi riserva una ricompensa eterna in cambio dei mali temporali religiosamente sopportati. Ma voi chi siete ché si debba parlar con voi per lo meno dei vostri dèi e tanto meno del mio Dio? Egli infatti è terribile su tutti gli dèi perché tutti gli dèi dei pagani sono demoni, il Signore invece ha creato i cieli 89".
30. Se vivesse il celebre Scipione Nasica, già vostro pontefice, che sotto la paura della guerra punica il senato, giacché si richiedeva un'ottima persona, elesse all'unanimità per accogliere gli dèi della Frigia 90 e che voi non ardireste di guardare in faccia, egli vi frenerebbe da questa vostra sfrontatezza. Perché afflitti dalle avversità vi lamentate della civiltà cristiana? Soltanto perché volete mantenere la vostra dissolutezza e andare alla deriva con costumi pervertiti senza sentire l'asprezza delle difficoltà. Infatti non desiderate avere la pace e abbondare di ricchezze per usar rettamente di questi beni, cioè con moderazione, sobrietà, temperanza e religiosità ma per procurarvi una varietà illimitata di piaceri con sperperi pazzeschi e per far sorgere con la prosperità quei mali nel costume che sono peggiori della crudeltà dei nemici. Ma Scipione, vostro pontefice massimo, quella persona ottima per giudizio di tutto il senato, temendo per voi questa sventura, non voleva che fosse distrutta Cartagine, allora emula della dominazione romana, e si opponeva a Catone il quale sosteneva che doveva essere distrutta 91. Scipione temeva che la sicurezza fosse nemica di animi deboli e pensava che la paura è indispensabile come idoneo tutore di cittadini, per dir così, minorenni. E non s'ingannava. I fatti provarono che aveva ragione. Cartagine fu distrutta, cioè fu allontanata e dissolta la grande paura dello Stato romano. E immediatamente seguirono mali molto gravi originati dal benessere. Infatti fu gravemente lacerata la concordia dapprima a causa di crudeli e sanguinose sedizioni, e subito dopo, data la congiuntura d'infauste circostanze, a causa anche di guerre civili furono compiute grandi stragi, fu versato molto sangue e si accese una sfrenata crudeltà per la cupidigia di confische e rapine. Così quei Romani che a causa di una vita più morale temevano mali dai nemici, essendo venuta a mancare la moralità pubblica, ne dovettero subire più crudeli dai concittadini. E la passione del dominio, che fra i tanti vizi del genere umano si era manifestata più mite nell'intero popolo romano, avendo trionfato in pochi più potenti, domò col giogo della schiavitù anche gli altri dopo averli messi a terra senza più forze.
31. E come poteva quietarsi in animi tanto superbi finché con cariche perpetue non fosse giunta al potere monarchico? Ma non si darebbe l'accesso a cariche perpetue se l'ambizione non prevalesse. E l'ambizione può prevalere soltanto in un popolo corrotto dall'amore alle ricchezze e al piacere. E il popolo fu reso dall'eccessivo benessere amante delle ricchezze e del piacere. Per questo Nasica con molta saggezza riteneva che l'eccessivo benessere si dovesse evitare, giacché non voleva che la città nemica più grande, forte e ricca fosse distrutta. Così la passione era inibita dal timore, la passione inibita non portava all'amore del piacere e frenato l'amore al piacere, neanche l'amore alle ricchezze infierisse. Con l'impedir questi vizi sarebbe nata e cresciuta una virtù vantaggiosa per lo Stato e sarebbe rimasta la libertà corrispondente a quella virtù. Da questo fatto anche e da un prudente amor di patria derivò che il sopra ricordato vostro sommo pontefice, eletto, è opportuno ripeterlo, dal senato di quel tempo con votazione unanime alla più alta carica, trattenne il senato, che aveva deciso di costruire la gradinata del teatro, da questo provvedimento e dalla speculazione. Con autorevole discorso li indusse a non tollerare che la depravazione greca s'insinuasse nella virile moralità della patria e si consentisse alla frivolezza straniera di scuotere e svigorire il valore romano. Ebbe tanta influenza con la sua autorità che il consiglio senatoriale, mosso dalle sue parole, proibì perfino che in seguito si disponessero i sedili che, ammucchiati per l'occasione, la cittadinanza aveva già cominciato ad usare per lo spettacolo 92. Con quale ardore egli avrebbe eliminato da Roma perfino le rappresentazioni teatrali, se avesse ardito resistere all'autorità di quelli che riconosceva come dèi, di cui non pensava che fossero demoni malefici o, se lo pensava, riteneva che si dovessero piuttosto placare che disprezzare. Infatti non era stata ancora rivelata ai pagani l'altissima dottrina che purificando il cuore con la fede volgesse l'umano sentimento mediante la pietà terrena a raggiungere le cose celesti e anche sopracelesti e lo liberasse dal dominio di demoni superbi.
29. Dunque tutta la servitù del sommo e vero Dio ha il suo conforto non menzognero e non fondato sulla speranza di cose incerte o caduche; ha anche la stessa vita terrena che non si deve affatto avere in uggia perché in essa la servitù stessa è educata alla vita eterna. Come esule inoltre usa senza rendersene schiava dei beni terreni ed è o provata o purificata dai mali. Ma alcuni insultano la sua moralità e le dicono, quando eventualmente incorre in determinate sciagure temporali: Dov'è il tuo Dio? 88. Dicano loro piuttosto dove sono i loro dèi quando subiscono tali sventure giacché li onorano e si affaticano a farli onorare proprio per evitarle. Essa può rispondere: "Il mio Dio è presente in ogni luogo, tutto in ogni luogo, non limitato nello spazio perché può esser presente senza rivelarsi, assente senza muoversi. Quando mi sprona con le avversità, o soppesa i meriti o punisce i peccati e mi riserva una ricompensa eterna in cambio dei mali temporali religiosamente sopportati. Ma voi chi siete ché si debba parlar con voi per lo meno dei vostri dèi e tanto meno del mio Dio? Egli infatti è terribile su tutti gli dèi perché tutti gli dèi dei pagani sono demoni, il Signore invece ha creato i cieli 89".
30. Se vivesse il celebre Scipione Nasica, già vostro pontefice, che sotto la paura della guerra punica il senato, giacché si richiedeva un'ottima persona, elesse all'unanimità per accogliere gli dèi della Frigia 90 e che voi non ardireste di guardare in faccia, egli vi frenerebbe da questa vostra sfrontatezza. Perché afflitti dalle avversità vi lamentate della civiltà cristiana? Soltanto perché volete mantenere la vostra dissolutezza e andare alla deriva con costumi pervertiti senza sentire l'asprezza delle difficoltà. Infatti non desiderate avere la pace e abbondare di ricchezze per usar rettamente di questi beni, cioè con moderazione, sobrietà, temperanza e religiosità ma per procurarvi una varietà illimitata di piaceri con sperperi pazzeschi e per far sorgere con la prosperità quei mali nel costume che sono peggiori della crudeltà dei nemici. Ma Scipione, vostro pontefice massimo, quella persona ottima per giudizio di tutto il senato, temendo per voi questa sventura, non voleva che fosse distrutta Cartagine, allora emula della dominazione romana, e si opponeva a Catone il quale sosteneva che doveva essere distrutta 91. Scipione temeva che la sicurezza fosse nemica di animi deboli e pensava che la paura è indispensabile come idoneo tutore di cittadini, per dir così, minorenni. E non s'ingannava. I fatti provarono che aveva ragione. Cartagine fu distrutta, cioè fu allontanata e dissolta la grande paura dello Stato romano. E immediatamente seguirono mali molto gravi originati dal benessere. Infatti fu gravemente lacerata la concordia dapprima a causa di crudeli e sanguinose sedizioni, e subito dopo, data la congiuntura d'infauste circostanze, a causa anche di guerre civili furono compiute grandi stragi, fu versato molto sangue e si accese una sfrenata crudeltà per la cupidigia di confische e rapine. Così quei Romani che a causa di una vita più morale temevano mali dai nemici, essendo venuta a mancare la moralità pubblica, ne dovettero subire più crudeli dai concittadini. E la passione del dominio, che fra i tanti vizi del genere umano si era manifestata più mite nell'intero popolo romano, avendo trionfato in pochi più potenti, domò col giogo della schiavitù anche gli altri dopo averli messi a terra senza più forze.
31. E come poteva quietarsi in animi tanto superbi finché con cariche perpetue non fosse giunta al potere monarchico? Ma non si darebbe l'accesso a cariche perpetue se l'ambizione non prevalesse. E l'ambizione può prevalere soltanto in un popolo corrotto dall'amore alle ricchezze e al piacere. E il popolo fu reso dall'eccessivo benessere amante delle ricchezze e del piacere. Per questo Nasica con molta saggezza riteneva che l'eccessivo benessere si dovesse evitare, giacché non voleva che la città nemica più grande, forte e ricca fosse distrutta. Così la passione era inibita dal timore, la passione inibita non portava all'amore del piacere e frenato l'amore al piacere, neanche l'amore alle ricchezze infierisse. Con l'impedir questi vizi sarebbe nata e cresciuta una virtù vantaggiosa per lo Stato e sarebbe rimasta la libertà corrispondente a quella virtù. Da questo fatto anche e da un prudente amor di patria derivò che il sopra ricordato vostro sommo pontefice, eletto, è opportuno ripeterlo, dal senato di quel tempo con votazione unanime alla più alta carica, trattenne il senato, che aveva deciso di costruire la gradinata del teatro, da questo provvedimento e dalla speculazione. Con autorevole discorso li indusse a non tollerare che la depravazione greca s'insinuasse nella virile moralità della patria e si consentisse alla frivolezza straniera di scuotere e svigorire il valore romano. Ebbe tanta influenza con la sua autorità che il consiglio senatoriale, mosso dalle sue parole, proibì perfino che in seguito si disponessero i sedili che, ammucchiati per l'occasione, la cittadinanza aveva già cominciato ad usare per lo spettacolo 92. Con quale ardore egli avrebbe eliminato da Roma perfino le rappresentazioni teatrali, se avesse ardito resistere all'autorità di quelli che riconosceva come dèi, di cui non pensava che fossero demoni malefici o, se lo pensava, riteneva che si dovessero piuttosto placare che disprezzare. Infatti non era stata ancora rivelata ai pagani l'altissima dottrina che purificando il cuore con la fede volgesse l'umano sentimento mediante la pietà terrena a raggiungere le cose celesti e anche sopracelesti e lo liberasse dal dominio di demoni superbi.
lunedì 21 marzo 2011
I Proverbi - Ventisettesimo appuntamento
Prosegue l'appuntamento del lunedì con Il Libro dei Proverbi. Oggi leggiamo e meditiamo il ventisettesimo capitolo:
1Non ti vantare del domani,
perché non sai neppure che cosa genera l'oggi.
2Ti lodi un altro e non la tua bocca,
un estraneo e non le tue labbra.
3La pietra è greve, la sabbia è pesante,
ma più dell'una e dell'altra lo è il fastidio dello stolto.
4La collera è crudele, l'ira è impetuosa;
ma chi può resistere alla gelosia?
5Meglio un rimprovero aperto
che un amore celato.
6Leali sono le ferite di un amico,
fallaci i baci di un nemico.
7Gola sazia disprezza il miele;
per chi ha fame anche l'amaro è dolce.
8Come un uccello che vola lontano dal nido
così è l'uomo che va errando lontano dalla dimora.
9Il profumo e l'incenso allietano il cuore,
la dolcezza di un amico rassicura l'anima.
10Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre,
non entrare nella casa di tuo fratello
nel giorno della tua disgrazia.
Meglio un amico vicino che un fratello lontano.
11Sii saggio, figlio mio, e allieterai il mio cuore
e avrò di che rispondere a colui che mi insulta.
12L'accorto vede il pericolo e si nasconde,
gli inesperti vanno avanti e la pagano.
13Prendigli il vestito perché si è fatto garante per uno straniero
e tienilo in pegno per gli sconosciuti.
14Benedire il prossimo di buon mattino ad alta voce
gli sarà imputato come una maledizione.
15Il gocciolar continuo in tempo di pioggia
e una moglie litigiosa, si rassomigliano:
16chi la vuol trattenere, trattiene il vento
e raccoglie l'olio con la mano destra.
17Il ferro si aguzza con il ferro
e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno.
18Il guardiano di un fico ne mangia i frutti,
chi ha cura del suo padrone ne riceverà onori.
19Come un volto differisce da un altro,
così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.
20Come gli inferi e l'abisso non si saziano mai,
così non si saziano mai gli occhi dell'uomo.
21Come il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro,
così l'uomo rispetto alla bocca di chi lo loda.
22Anche se tu pestassi lo stolto nel mortaio
tra i grani con il pestello,
non scuoteresti da lui la sua stoltezza.
23Preòccupati del tuo gregge,
abbi cura delle tue mandrie,
24perché non sono perenni le ricchezze,
né un tesoro si trasmette di generazione in generazione.
25Si toglie il fieno, apparisce l'erba nuova
e si raccolgono i foraggi dei monti;
26gli agnelli ti danno le vesti
e i capretti il prezzo per comprare un campo,
27le capre latte abbondante per il cibo
e per vitto della tua famiglia.
e per mantenere le tue schiave.
COMMENTO
Significativa la frase con la quale esordisce questo capitolo ventisette. Ci sono uomini infatti che dicono: "Domani farò questa grande opera", vantandosi di capacità non loro, ma non sanno che il Signore potrebbe richiedere loro la vita nel giorno stesso. L'umiltà è la vela che permette di percorrere il mare della santità; la vela da sola non si gonfia, ma è gonfiata dal vento. Così l'umile sarà esaltato da Dio e navigherà i mari che conducono ai lidi della salvezza. Prosegue infatti il capitolo che abbiamo appena letto, dicendo che siano gli altri a lodare l'uomo ma non l'uomo sé stesso. La superbia è un pericolo per chi l'accresce nel proprio cuore; c'è chi per un atto di superbia rischia la vita e la perde. La superbia equivale a una brusca sterzata che fa ribaltare la macchina. Guai all'uomo che si esalta e si fa i complimenti da solo, perché perderebbe di vista quanto di buono ha imparato, sviando e perdendosi. E' necessario praticare ogni giorno la santa virtù dell'umiltà senza mai sperare di ricevere in cambio lodi o doni per le proprie azioni.
In conclusione ci soffermiamo sulla frase dei versetti 6 e 7. I ricchi disprezzano ciò che è buono perché sono abituati a lussi, mentre i poveri come abbiamo potuto anche ascoltare dalle drammatiche testimonianze che ci sono pervenute in passato da Haiti o più recentemente dalla Corea del Nord, paesi nei quali i poveri sono costretti a mangiar la terra. Allora vediamo i ricchi viziati lamentarsi di un cibo prelibato perché abituati a pietanze costosissime, mentre i poveri si accontentano anche di un cibo amaro. Un giorno però, e noi ne siamo certi, i ricchi se non si convertiranno, nemmeno l'amaro ci sarà per loro ma fame e sete eterna, i poveri invece avranno di che sfamarsi, in eterno, e noi lo crediamo perché fidenti nella promessa di Cristo nostro Signore.
domenica 20 marzo 2011
Il Libro di Giobbe - Ventisettesimo appuntamento
Prosegue l'appuntamento anche per questa domenica con Il Libro di Giobbe; oggi prosegue il discorso di Giobbe che assume connotazioni profondamente malinconiche:
COMMENTO
Continua il discorso di Giobbe che oggi diventa, come preannunciato settimana scorsa, molto malinconico e nostalgico. Egli ricorda infatti i tempi gloriosi in cui si sentiva veramente benedetto dal Signore e dalle sue parole traspaiono i fatti che comprovano questo stato. Vediamo come era considerato e vediamo anche come tutti lo rispettavano e lo benedicevano. Certamente è facilmente comprensibile vedere questa malinconia nel discorso di Giobbe poiché egli è ora non solo si sente lontano da Dio, ma soprattutto si ritrova ad esser deriso e accusato da coloro che considerava amici.
Qualsiasi uomo si sentirebbe come Giobbe: un passato glorioso ed un presente doloroso e di derisione comportano inevitabilmente il rimpiangere i momenti passati e allo stesso tempo, tutto ciò comporta una riflessione sul perchè è avvenuto questo cambiamento così profondo. Ma questa è un'altra storia di cui ne scopriremo i tratti nelle prossime settimane che rappresenteranno la conclusione del Libro di Giobbe, dove ogni verità sarà finalmente svelata.
29
[1]Giobbe continuò a pronunziare le sue sentenze e disse:
[2]Oh, potessi tornare com'ero ai mesi di un tempo,
ai giorni in cui Dio mi proteggeva,
[3]quando brillava la sua lucerna sopra il mio capo
e alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre;
[4]com'ero ai giorni del mio autunno,
quando Dio proteggeva la mia tenda,
[5]quando l'Onnipotente era ancora con me
e i giovani mi stavano attorno;
[6]quando mi lavavo in piedi nel latte
e la roccia mi versava ruscelli d'olio!
[7]Quando uscivo verso la porta della città
e sulla piazza ponevo il mio seggio:
[8]vedendomi, i giovani si ritiravano
e i vecchi si alzavano in piedi;
[9]i notabili sospendevano i discorsi
e si mettevan la mano sulla bocca;
[10]la voce dei capi si smorzava
e la loro lingua restava fissa al palato;
[11]con gli orecchi ascoltavano e mi dicevano felice,
con gli occhi vedevano e mi rendevano testimonianza,
[12]perché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto,
l'orfano che ne era privo.
[13]La benedizione del morente scendeva su di me
e al cuore della vedova infondevo la gioia.
[14]Mi ero rivestito di giustizia come di un vestimento;
come mantello e turbante era la mia equità.
[15]Io ero gli occhi per il cieco,
ero i piedi per lo zoppo.
[16]Padre io ero per i poveri
ed esaminavo la causa dello sconosciuto;
[17]rompevo la mascella al perverso
e dai suoi denti strappavo la preda.
[18]Pensavo: «Spirerò nel mio nido
e moltiplicherò come sabbia i miei giorni».
[19]La mia radice avrà adito alle acque
e la rugiada cadrà di notte sul mio ramo.
[20]La mia gloria sarà sempre nuova
e il mio arco si rinforzerà nella mia mano.
[21]Mi ascoltavano in attesa fiduciosa
e tacevano per udire il mio consiglio.
[22]Dopo le mie parole non replicavano
e su di loro scendevano goccia a goccia i miei detti.
[23]Mi attendevano come si attende la pioggia
e aprivano la bocca come ad acqua primaverile.
[24]Se a loro sorridevo, non osavano crederlo,
né turbavano la serenità del mio volto.
[25]Indicavo loro la via da seguire e sedevo come capo,
e vi rimanevo come un re fra i soldati
o come un consolatore d'afflitti.
[2]Oh, potessi tornare com'ero ai mesi di un tempo,
ai giorni in cui Dio mi proteggeva,
[3]quando brillava la sua lucerna sopra il mio capo
e alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre;
[4]com'ero ai giorni del mio autunno,
quando Dio proteggeva la mia tenda,
[5]quando l'Onnipotente era ancora con me
e i giovani mi stavano attorno;
[6]quando mi lavavo in piedi nel latte
e la roccia mi versava ruscelli d'olio!
[7]Quando uscivo verso la porta della città
e sulla piazza ponevo il mio seggio:
[8]vedendomi, i giovani si ritiravano
e i vecchi si alzavano in piedi;
[9]i notabili sospendevano i discorsi
e si mettevan la mano sulla bocca;
[10]la voce dei capi si smorzava
e la loro lingua restava fissa al palato;
[11]con gli orecchi ascoltavano e mi dicevano felice,
con gli occhi vedevano e mi rendevano testimonianza,
[12]perché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto,
l'orfano che ne era privo.
[13]La benedizione del morente scendeva su di me
e al cuore della vedova infondevo la gioia.
[14]Mi ero rivestito di giustizia come di un vestimento;
come mantello e turbante era la mia equità.
[15]Io ero gli occhi per il cieco,
ero i piedi per lo zoppo.
[16]Padre io ero per i poveri
ed esaminavo la causa dello sconosciuto;
[17]rompevo la mascella al perverso
e dai suoi denti strappavo la preda.
[18]Pensavo: «Spirerò nel mio nido
e moltiplicherò come sabbia i miei giorni».
[19]La mia radice avrà adito alle acque
e la rugiada cadrà di notte sul mio ramo.
[20]La mia gloria sarà sempre nuova
e il mio arco si rinforzerà nella mia mano.
[21]Mi ascoltavano in attesa fiduciosa
e tacevano per udire il mio consiglio.
[22]Dopo le mie parole non replicavano
e su di loro scendevano goccia a goccia i miei detti.
[23]Mi attendevano come si attende la pioggia
e aprivano la bocca come ad acqua primaverile.
[24]Se a loro sorridevo, non osavano crederlo,
né turbavano la serenità del mio volto.
[25]Indicavo loro la via da seguire e sedevo come capo,
e vi rimanevo come un re fra i soldati
o come un consolatore d'afflitti.
COMMENTO
Continua il discorso di Giobbe che oggi diventa, come preannunciato settimana scorsa, molto malinconico e nostalgico. Egli ricorda infatti i tempi gloriosi in cui si sentiva veramente benedetto dal Signore e dalle sue parole traspaiono i fatti che comprovano questo stato. Vediamo come era considerato e vediamo anche come tutti lo rispettavano e lo benedicevano. Certamente è facilmente comprensibile vedere questa malinconia nel discorso di Giobbe poiché egli è ora non solo si sente lontano da Dio, ma soprattutto si ritrova ad esser deriso e accusato da coloro che considerava amici.
Qualsiasi uomo si sentirebbe come Giobbe: un passato glorioso ed un presente doloroso e di derisione comportano inevitabilmente il rimpiangere i momenti passati e allo stesso tempo, tutto ciò comporta una riflessione sul perchè è avvenuto questo cambiamento così profondo. Ma questa è un'altra storia di cui ne scopriremo i tratti nelle prossime settimane che rappresenteranno la conclusione del Libro di Giobbe, dove ogni verità sarà finalmente svelata.
sabato 19 marzo 2011
Il Sabato dei Salmi - Salmo 46 (45) - Dio è con noi
Salmo 46
Dio è con noi
[1]Al maestro del coro. Dei figli di Core.
Su «Le vergini...». Canto.
[2]Dio è per noi rifugio e forza,
aiuto sempre vicino nelle angosce.
[3]Perciò non temiamo se trema la terra,
se crollano i monti nel fondo del mare.
[4]Fremano, si gonfino le sue acque,
tremino i monti per i suoi flutti.
[5]Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio,
la santa dimora dell'Altissimo.
[6]Dio sta in essa: non potrà vacillare;
la soccorrerà Dio, prima del mattino.
[7]Fremettero le genti, i regni si scossero;
egli tuonò, si sgretolò la terra.
[8]Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
[9]Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto portenti sulla terra.
[10]Farà cessare le guerre sino ai confini della terra,
romperà gli archi e spezzerà le lance,
brucerà con il fuoco gli scudi.
[11]Fermatevi e sappiate che io sono Dio,
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
[12]Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
COMMENTO
Qual commento migliore di questo poteva capitarci per questa settimana! Il Signore è il nostro reale rifugio: non appena abbiamo una tribolazione, un'angoscia, un lutto, la prima cosa che facciamo è dire: "Gesù aiutami Tu"! E da questo semplice ma efficace abbandono in Cristo quanto sollievo e quanta freschezza sentiamo effondersi nel nostro cuore! Il Signore è realmente il nostro unico rifugio dove poter riposare l'animo in ogni sorta di sofferenza. Dice il Salmo: "Perciò non tremiamo se trema la terra". A queste parole subito tornano alla mente i disastrosi fatti del Giappone. Si stanno verificando fatti dolorosi in varie parti del mondo e questo sicuramente suscita dolore e compassione verso i nostri cari fratelli del Sol Levante. Oltre a questo i fatti libici preoccupano la nostra nazione per le minacce del governatore libico. Ma proprio perché il Signore è il nostro rifugio, nonostante tutte le tribolazioni che si stanno succedendo sulla terra, noi siamo tranquilli perché in Lui non c'è da aver paura. Dice ad un certo punto il Salmo, tremi pure la terra, crolli pure il mondo, per modo di dire, noi non abbiamo paura perché il Signore è con noi. Confidare nell'unico e vero Dio e cioè il Dio di Giacobbe ovvero il Dio d'Israele è confidare nell'unica e vera fortezza, è un rifugiarsi nell'unico e sicuro rifugio.
Noi in qualsiasi, ma dico proprio qualsiasi situazione dolorosa nella quale ci troviamo, noi dobbiamo sempre rifugiarci nel Signore, dobbiamo parlare a Lui come figli perché noi siamo diventati Suoi figli nel giorno del Battesimo! Gesù dice: "Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi" (Gv 15,15). Essere servi di Cristo non escludere l'essere amici ed essere amici di Cristo non esclude l'essere Suoi servi. Ovvero l'uomo deve essere servo di Cristo e allo stesso tempo Gesù vede i Suoi servi non come schiavi, ma come amici! Noi siamo amici di Dio, fratelli di Cristo, figli del Padre! Noi verso Dio dobbiamo sempre assumere un atteggiamento di rispetto, ma nel contempo essendo diventati figli per Sua Volontà, noi dobbiamo rivolgerci a Lui con cuore di figli. Il Signore ci ha dato la grazia di poteri accostare a Lui con timore e allo stesso tempo con confidenza di figli. Pensiamoci bene: l'Onnipotente ci permette di chiamarLo "Padre". Oggi è San Giuseppe, festa del papà e in questa giornata alziamo il cuore verso Dio e diciamo il più bel Padre nostro della nostra vita: saremo in Lui rifugiati da ogni male: niente potrà spaventarci se siamo in Sua compagnia.
Dio è con noi, è il nome dell'Emmanuele, è il nome di Gesù che vuol dire infatti: Dio con noi. Dio è veramente con noi nella persona di Gesù Cristo! Dobbiamo essere felicissimi perché Dio è venuto in mezzo a noi ed è rimasto assieme a noi, accanto a noi in ogni nostro attimo di vita, in special modo è nel dolcissimo Sacramento dell'Eucarestia: Gesù mio immenso amore, donami sempre più amore perché io te ne possa dare sempre più! Questo dobbiamo dire al Signore Gesù ogni giorno della nostra vita, dobbiamo amare tanto, tanto, tanto il Signore nostro, il nostro unico e sicuro rifugio!
venerdì 18 marzo 2011
Siracide - Venticinquesimo appuntamento
Prosegue l'appuntamento del venerdì con il Siracide, giunto quest'oggi al venticinquesimo capitolo incentrato sui proverbi della Sapienza:
COMMENTO
Continua il discorso della Sapienza di Dio che oggi ci arricchisce attraverso alcuni proverbi molto intensi e significativi. Ancora una volta ci viene mostrato la figura di colui che è disprezzato: un povero superbo, un ricco bugiardo, un vecchio adultero privo di senno. Queste figure rappresentano l'uomo che vive lontano da Dio perchè troppo preso dal peccato: in particolare la superbia è il contrario dell'umiltà, la bugia è il contrario della verità e l'adulterio è il contrario della fedeltà. Il figlio di Dio deve rappresentare appunto il contrario e cioè umiltà, verità e fedeltà e solo così potrà definirsi degno di esser chiamato figlio di Dio!
Troviamo ancora un riferimento alla figura dell'anziano e l'invito ad ascoltarlo si concretizza con le parole che ne elogiano la sapienza.
Ma soprattutto questi proverbi sembrano per lo più indirizzati alla figura della donna ed in particolare alla figura della donna malvagia, maliziosa, tentatrice. Noi sappiamo che il peccato è entrato nel mondo a causa dell'infedeltà di Eva, ma quell'infedeltà si è trasmessa nelle donne di generazione in generazione rendendola facilmente manipolabile dal male come oggetto di seduzione. Ma Dio non ha lasciato che la donna fosse usata dal nemico, ma ha fatto in modo di benedire le donne attraverso Maria che con la sua umiltà e obbedienza si è guadagnata il favore dell'Altissimo. Attraverso Maria, la donna ha la possibilità di invertire la rotta di questi proverbi e di dimostrare di esser lontana dalla figura descritta dal Siracide: purtroppo ci sono donne che non recepiscono questo messaggio e finiscono con il divenire soggetti di malvagità che si traduce nel carattere seducente e malizioso. La storia ci riempie di numerosi esempi di donne che con malizia hanno raggirato uomini solo per la propria personale soddisfazione. Ma per fortuna, la storia ci ha mostrato un'infinità di esempi di donne che hanno saputo vivere con virtù e anche con feconda santità (Santa Chiara d'Assisi o Santa Teresa d'Avila sono solo un esempio di come la donna possa vivere secondo virtù e santità). Le donne di oggi sono chiamate a seguire questi giusti esempi e a condurre una vita che sia integra e sobria come del resto anche gli uomini sono chiamati a vivere una vita integra, sobria e in umiltà.
1Di tre cose mi compiaccio e mi faccio bella,
di fronte al Signore e agli uomini:
concordia di fratelli, amicizia tra vicini,
moglie e marito che vivono in piena armonia.
2Tre tipi di persone io detesto,
la loro vita è per me un grande orrore:
un povero superbo, un ricco bugiardo,
un vecchio adultero privo di senno.
3Nella giovinezza non hai raccolto;
come potresti procurarti qualcosa nella vecchiaia?
4Come s'addice il giudicare ai capelli bianchi,
e agli anziani intendersi di consigli!
5Come s'addice la sapienza ai vecchi,
il discernimento e il consiglio alle persone eminenti!
6Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice,
loro vanto il timore del Signore.
7Nove situazioni io ritengo felici nel mio cuore,
la decima la dirò con le parole:
un uomo allietato dai figli,
chi vede da vivo la caduta dei suoi nemici;
8felice chi vive con una moglie assennata,
colui che non pecca con la sua lingua,
chi non deve servire a uno indegno di lui;
9fortunato chi ha trovato la prudenza,
chi si rivolge a orecchi attenti;
10quanto è grande chi ha trovato la sapienza,
ma nessuno supera chi teme il Signore.
11Il timore del Signore è più di ogni cosa;
chi lo possiede a chi potrà esser paragonato?
12Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore;
qualunque malvagità, ma non la malvagità di una donna;
13qualunque sventura, ma non la sventura
causata dagli avversari;
qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici.
14Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente,
non c'è ira peggiore dell'ira di un nemico.
15Preferirei abitare con un leone e con un drago
piuttosto che abitare con una donna malvagia.
16La malvagità di una donna ne àltera l'aspetto,
ne rende il volto tetro come quello di un orso.
17Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini
e ascoltandoli geme amaramente.
18Ogni malizia è nulla, di fronte alla malizia di una donna,
possa piombarle addosso la sorte del peccatore!
19Come una salita sabbiosa per i piedi di un vecchio,
tale la donna linguacciuta per un uomo pacifico.
20Non soccombere al fascino di una donna,
per una donna non ardere di passione.
21Motivo di sdegno, di rimprovero e di grande disprezzo
è una donna che mantiene il proprio marito.
22Animo abbattuto e volto triste
e ferita al cuore è una donna malvagia;
23mani inerti e ginocchia infiacchite,
tale colei che non rende felice il proprio marito.
24Dalla donna ha avuto inizio il peccato,
per causa sua tutti moriamo.
25Non dare all'acqua un'uscita
né libertà di parlare a una donna malvagia.
26Se non cammina al cenno della tua mano,
toglila dalla tua presenza.
di fronte al Signore e agli uomini:
concordia di fratelli, amicizia tra vicini,
moglie e marito che vivono in piena armonia.
2Tre tipi di persone io detesto,
la loro vita è per me un grande orrore:
un povero superbo, un ricco bugiardo,
un vecchio adultero privo di senno.
3Nella giovinezza non hai raccolto;
come potresti procurarti qualcosa nella vecchiaia?
4Come s'addice il giudicare ai capelli bianchi,
e agli anziani intendersi di consigli!
5Come s'addice la sapienza ai vecchi,
il discernimento e il consiglio alle persone eminenti!
6Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice,
loro vanto il timore del Signore.
7Nove situazioni io ritengo felici nel mio cuore,
la decima la dirò con le parole:
un uomo allietato dai figli,
chi vede da vivo la caduta dei suoi nemici;
8felice chi vive con una moglie assennata,
colui che non pecca con la sua lingua,
chi non deve servire a uno indegno di lui;
9fortunato chi ha trovato la prudenza,
chi si rivolge a orecchi attenti;
10quanto è grande chi ha trovato la sapienza,
ma nessuno supera chi teme il Signore.
11Il timore del Signore è più di ogni cosa;
chi lo possiede a chi potrà esser paragonato?
12Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore;
qualunque malvagità, ma non la malvagità di una donna;
13qualunque sventura, ma non la sventura
causata dagli avversari;
qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici.
14Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente,
non c'è ira peggiore dell'ira di un nemico.
15Preferirei abitare con un leone e con un drago
piuttosto che abitare con una donna malvagia.
16La malvagità di una donna ne àltera l'aspetto,
ne rende il volto tetro come quello di un orso.
17Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini
e ascoltandoli geme amaramente.
18Ogni malizia è nulla, di fronte alla malizia di una donna,
possa piombarle addosso la sorte del peccatore!
19Come una salita sabbiosa per i piedi di un vecchio,
tale la donna linguacciuta per un uomo pacifico.
20Non soccombere al fascino di una donna,
per una donna non ardere di passione.
21Motivo di sdegno, di rimprovero e di grande disprezzo
è una donna che mantiene il proprio marito.
22Animo abbattuto e volto triste
e ferita al cuore è una donna malvagia;
23mani inerti e ginocchia infiacchite,
tale colei che non rende felice il proprio marito.
24Dalla donna ha avuto inizio il peccato,
per causa sua tutti moriamo.
25Non dare all'acqua un'uscita
né libertà di parlare a una donna malvagia.
26Se non cammina al cenno della tua mano,
toglila dalla tua presenza.
COMMENTO
Continua il discorso della Sapienza di Dio che oggi ci arricchisce attraverso alcuni proverbi molto intensi e significativi. Ancora una volta ci viene mostrato la figura di colui che è disprezzato: un povero superbo, un ricco bugiardo, un vecchio adultero privo di senno. Queste figure rappresentano l'uomo che vive lontano da Dio perchè troppo preso dal peccato: in particolare la superbia è il contrario dell'umiltà, la bugia è il contrario della verità e l'adulterio è il contrario della fedeltà. Il figlio di Dio deve rappresentare appunto il contrario e cioè umiltà, verità e fedeltà e solo così potrà definirsi degno di esser chiamato figlio di Dio!
Troviamo ancora un riferimento alla figura dell'anziano e l'invito ad ascoltarlo si concretizza con le parole che ne elogiano la sapienza.
Ma soprattutto questi proverbi sembrano per lo più indirizzati alla figura della donna ed in particolare alla figura della donna malvagia, maliziosa, tentatrice. Noi sappiamo che il peccato è entrato nel mondo a causa dell'infedeltà di Eva, ma quell'infedeltà si è trasmessa nelle donne di generazione in generazione rendendola facilmente manipolabile dal male come oggetto di seduzione. Ma Dio non ha lasciato che la donna fosse usata dal nemico, ma ha fatto in modo di benedire le donne attraverso Maria che con la sua umiltà e obbedienza si è guadagnata il favore dell'Altissimo. Attraverso Maria, la donna ha la possibilità di invertire la rotta di questi proverbi e di dimostrare di esser lontana dalla figura descritta dal Siracide: purtroppo ci sono donne che non recepiscono questo messaggio e finiscono con il divenire soggetti di malvagità che si traduce nel carattere seducente e malizioso. La storia ci riempie di numerosi esempi di donne che con malizia hanno raggirato uomini solo per la propria personale soddisfazione. Ma per fortuna, la storia ci ha mostrato un'infinità di esempi di donne che hanno saputo vivere con virtù e anche con feconda santità (Santa Chiara d'Assisi o Santa Teresa d'Avila sono solo un esempio di come la donna possa vivere secondo virtù e santità). Le donne di oggi sono chiamate a seguire questi giusti esempi e a condurre una vita che sia integra e sobria come del resto anche gli uomini sono chiamati a vivere una vita integra, sobria e in umiltà.
giovedì 17 marzo 2011
Catechismo della Chiesa Cattolica - XVII parte
Proseguiamo il nostro percorso volto alla conoscenza del Catechismo della Chiesa Cattolica: abbiamo letto la scorsa settimana il Paragrafo 5: "Il Cielo e la Terra"; oggi invece proseguiamo con il Paragrafo 6 che ci parlerà della nostra natura: l'uomo.
Paragrafo 6
L'UOMO
355 « Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò » (Gn 1,27). L'uomo, nella creazione, occupa un posto unico: egli è « a immagine di Dio » (I); nella sua natura unisce il mondo spirituale e il mondo materiale (II); è creato « maschio e femmina » (III); Dio l'ha stabilito nella sua amicizia (IV).
I. «A immagine di Dio»
356 Di tutte le creature visibili, soltanto l'uomo è « capace di conoscere e di amare il proprio Creatore »; 459 « è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa »; 460 soltanto l'uomo è chiamato a condividere, nella conoscenza e nell'amore, la vita di Dio. A questo fine è stato creato ed è questa la ragione fondamentale della sua dignità.
« Quale fu la ragione che tu ponessi l'uomo in tanta dignità? Certo l'amore inestimabile con il quale hai guardato in te medesimo la tua creatura e ti sei innamorato di lei; per amore infatti tu l'hai creata, per amore tu le hai dato un essere capace di gustare il tuo Bene eterno ». 461
357 Essendo ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone; è chiamato, per grazia, ad un'alleanza con il suo Creatore, a dargli una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare in sua sostituzione.
358 Dio ha creato tutto per l'uomo, 462 ma l'uomo è stato creato per servire e amare Dio e per offrirgli tutta la creazione:
« Qual è dunque l'essere che deve venire all'esistenza circondato di una tale considerazione? È l'uomo, grande e meravigliosa figura vivente, più prezioso agli occhi di Dio dell'intera creazione: è l'uomo, è per lui che esistono il cielo e la terra e il mare e la totalità della creazione, ed è alla sua salvezza che Dio ha dato tanta importanza da non risparmiare, per lui, neppure il suo Figlio unigenito. Dio infatti non ha mai cessato di tutto mettere in atto per far salire l'uomo fino a sé e farlo sedere alla sua destra ». 463
359 « In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo »: 464
« Il beato Apostolo ci ha fatto sapere che due uomini hanno dato principio al genere umano: Adamo e Cristo. [...] Il primo uomo, Adamo, – dice – divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Quel primo fu creato da quest'ultimo, dal quale ricevette l'anima per vivere. [...] Il secondo Adamo plasmò il primo e gli impresse la propria immagine. E così avvenne poi che egli ne prese la natura e il nome, per non dover perdere ciò che egli aveva fatto a sua immagine. C'è un primo Adamo e c'è un ultimo Adamo. Il primo ha un inizio, l'ultimo non ha fine. Proprio quest'ultimo infatti è veramente il primo, dal momento che dice: "Sono io, io solo, il primo e anche l'ultimo" ». 465
360 A motivo della comune origine il genere umano forma una unità. Dio infatti « creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini » (At 17,26): 466
« Meravigliosa visione che ci fa contemplare il genere umano nell'unità della sua origine in Dio [...]; nell'unità della sua natura, composta ugualmente presso tutti di un corpo materiale e di un'anima spirituale; nell'unità del suo fine immediato e della sua missione nel mondo; nell'unità del suo "habitat": la terra, dei cui beni tutti gli uomini, per diritto naturale, possono usare per sostentare e sviluppare la vita; nell'unità del suo fine soprannaturale: Dio stesso, al quale tutti devono tendere; nell'unità dei mezzi per raggiungere tale fine; [...] nell'unità del suo riscatto operato per tutti da Cristo ». 467
361 « Questa legge di solidarietà umana e di carità », 468 senza escludere la ricca varietà delle persone, delle culture e dei popoli, ci assicura che tutti gli uomini sono veramente fratelli.
II. «Corpore et anima unus» - Unità di anima e di corpo
362 La persona umana, creata a immagine di Dio, è un essere insieme corporeo e spirituale. Il racconto biblico esprime questa realtà con un linguaggio simbolico, quando dice: « Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente » (Gn 2,7). L'uomo tutto intero è quindi voluto da Dio.
363 Spesso, nella Sacra Scrittura, il termine anima indica la vita umana, 469 oppure tutta la persona umana. 470 Ma designa anche tutto ciò che nell'uomo vi è di più intimo 471 e di maggior valore, 472 ciò per cui più particolarmente egli è immagine di Dio: « anima » significa il principio spirituale nell'uomo.
364 Il corpo dell'uomo partecipa alla dignità di « immagine di Dio »: è corpo umano proprio perché è animato dall'anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere destinata a diventare, nel corpo di Cristo, il tempio dello Spirito. 473
« Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la sua stessa condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso di lui, toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Allora, non è lecito all'uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno ». 474
365 L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che si deve considerare l'anima come la « forma » del corpo; 475 ciò significa che grazie all'anima spirituale il corpo, composto di materia, è un corpo umano e vivente; lo spirito e la materia, nell'uomo, non sono due nature congiunte, ma la loro unione forma un'unica natura.
366 La Chiesa insegna che ogni anima spirituale è creata direttamente da Dio 476 – non è « prodotta » dai genitori – ed è immortale: 477 essa non perisce al momento della sua separazione dal corpo nella morte, e di nuovo si unirà al corpo al momento della risurrezione finale.
367 Talvolta si dà il caso che l'anima sia distinta dallo spirito. Così san Paolo prega perché il nostro essere tutto intero, « spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore » (1 Ts 5,23). La Chiesa insegna che tale distinzione non introduce una dualità nell'anima. 478 « Spirito » significa che sin dalla sua creazione l'uomo è ordinato al suo fine soprannaturale, 479 e che la sua anima è capace di essere gratuitamente elevata alla comunione con Dio. 480
368 La tradizione spirituale della Chiesa insiste anche sul cuore, nel senso biblico di « profondità dell'essere » (« in visceribus »: Ger 31,33), dove la persona si decide o non si decide per Dio. 481
III. «Maschio e femmina li creò»
Uguaglianza e diversità volute da Dio
369 L'uomo e la donna sono creati, cioè sono voluti da Dio: in una perfetta uguaglianza, per un verso, in quanto persone umane, e, per l'altro verso, nel loro rispettivo essere di maschio e di femmina. « Essere uomo », « essere donna » è una realtà buona e voluta da Dio: l'uomo e la donna hanno una insopprimibile dignità, che viene loro direttamente da Dio, loro Creatore. 482 L'uomo e la donna sono, con una identica dignità, « a immagine di Dio ». Nel loro « essere-uomo » ed « essere-donna », riflettono la sapienza e la bontà del Creatore.
370 Dio non è a immagine dell'uomo. Egli non è né uomo né donna. Dio è puro spirito, e in lui, perciò, non c'è spazio per le differenze di sesso. Ma le « perfezioni » dell'uomo e della donna riflettono qualche cosa dell'infinita perfezione di Dio: quelle di una madre 483 e quelle di un padre e di uno sposo. 484
«L'uno per l'altro» - «una unità a due»
371 Creati insieme, l'uomo e la donna sono voluti da Dio l'uno per l'altro. La Parola di Dio ce lo lascia capire attraverso diversi passi del testo sacro. « Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile » (Gn 2,18). Nessuno degli animali può essere questo « pari » dell'uomo. 485 La donna che Dio « plasma » con la costola tolta all'uomo e che conduce all'uomo, strappa all'uomo un grido d'ammirazione, un'esclamazione d'amore e di comunione: « Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa » (Gn 2,23). L'uomo scopre la donna come un altro « io » della stessa umanità.
372 L'uomo e la donna sono fatti « l'uno per l'altro »: non già che Dio li abbia creati « a metà » ed « incompleti »; li ha creati per una comunione di persone, nella quale ognuno può essere « aiuto » per l'altro, perché sono ad un tempo uguali in quanto persone (« osso dalle mie ossa... ») e complementari in quanto maschio e femmina. 486 Nel matrimonio, Dio li unisce in modo che, formando « una sola carne » (Gn 2,24), possano trasmettere la vita umana: « Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra » (Gn 1,28). Trasmettendo ai loro figli la vita umana, l'uomo e la donna, come sposi e genitori, cooperano in un modo unico all'opera del Creatore. 487
373 Nel disegno di Dio, l'uomo e la donna sono chiamati a dominare la terra 488 come « amministratori » di Dio. Questa sovranità non deve essere un dominio arbitrario e distruttivo. A immagine del Creatore, « che ama tutte le cose esistenti » (Sap 11,24), l'uomo e la donna sono chiamati a partecipare alla Provvidenza divina verso le altre creature. Da qui la loro responsabilità nei confronti del mondo che Dio ha loro affidato.
IV. L'uomo nel paradiso
374 Il primo uomo non solo è stato creato buono, ma è stato anche costituito in una tale amicizia con il suo Creatore e in una tale armonia con se stesso e con la creazione, che saranno superate soltanto dalla gloria della nuova creazione in Cristo.
375 La Chiesa, interpretando autenticamente il simbolismo del linguaggio biblico alla luce del Nuovo Testamento e della Tradizione, insegna che i nostri progenitori Adamo ed Eva sono stati costituiti in uno stato di santità e di giustizia originali. 489 La grazia della santità originale era una partecipazione alla vita divina. 490
376 Tutte le dimensioni della vita dell'uomo erano potenziate dall'irradiamento di questa grazia. Finché fosse rimasto nell'intimità divina, l'uomo non avrebbe dovuto né morire, 491 né soffrire. 492 L'armonia interiore della persona umana, l'armonia tra l'uomo e la donna, 493 infine l'armonia tra la prima coppia e tutta la creazione costituiva la condizione detta « giustizia originale ».
377 Il « dominio » del mondo che Dio, fin dagli inizi, aveva concesso all'uomo, si realizzava innanzi tutto nell'uomo stesso come padronanza di sé. L'uomo era integro e ordinato in tutto il suo essere, perché libero dalla triplice concupiscenza 494 che lo rende schiavo dei piaceri dei sensi, della cupidigia dei beni terreni e dell'affermazione di sé contro gli imperativi della ragione.
378 Il segno della familiarità dell'uomo con Dio è il fatto che Dio lo colloca nel giardino, 495 dove egli vive « per coltivarlo e custodirlo » (Gn 2,15): il lavoro non è una fatica penosa, 496 ma la collaborazione dell'uomo e della donna con Dio nel portare a perfezione la creazione visibile.
379 Per il peccato dei nostri progenitori andrà perduta tutta l'armonia della giustizia originale che Dio, nel suo disegno, aveva previsto per l'uomo.
In sintesi
380 « Padre santo,... a tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché, nell'obbedienza a te, suo Creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato». 497
381 L'uomo è predestinato a riprodurre l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo – « immagine del Dio invisibile » (Col 1,15) – affinché Cristo sia il primogenito di una moltitudine di fratelli e sorelle. 498
382 L'uomo è « unità di anima e di corpo ». 499 La dottrina della fede afferma che l'anima spirituale e immortale è creata direttamente da Dio.
383 « Dio non creò l'uomo lasciandolo solo: fin da principio "maschio e femmina li creò" (Gn 1,27), e la loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone ». 500
384 La Rivelazione ci fa conoscere lo stato di santità e di giustizia originali dell'uomo e della donna prima del peccato: dalla loro amicizia con Dio derivava la felicità della loro esistenza nel paradiso.
mercoledì 16 marzo 2011
Verità della Fede - VIII parte
Prosegue l'approfondimento sulle "Verità della Fede" attraverso le attente analisi di Sant'Alfonso Maria de' Liguori con il Paragrafo 2 del Cap. VI nel quale il Santo Vescovo Dottore della Chiesa e Fondatore dei Redentoristi confuta le opinioni di Epicuro, Hobbes e Stratone i quali sostengono che la materia possa pensare. Toccherà dunque al de' Liguori (Santo) dimostrare il contrario, ovvero che il pensiero è di natura spirituale e non materiale come sostenuto dai tre sopra elencati.
Immergiamoci dunque in questa lettura apologetica accessibile a chiunque grazie al lavoro del Santo Vescovo partenopeo il quale preghiamo perché ci aiuti a meditare e a conservare nel cuore queste sante meditazioni, sperando possano essere di aiuto non solo a noi ma anche a quanti desiderano accostarsi alle "Verità della Fede" facilmente comprensibili grazie a quest'operetta del Fondatore dei Redentoristi:
Immergiamoci dunque in questa lettura apologetica accessibile a chiunque grazie al lavoro del Santo Vescovo partenopeo il quale preghiamo perché ci aiuti a meditare e a conservare nel cuore queste sante meditazioni, sperando possano essere di aiuto non solo a noi ma anche a quanti desiderano accostarsi alle "Verità della Fede" facilmente comprensibili grazie a quest'operetta del Fondatore dei Redentoristi:
Verità della Fede
di Sant'Alfonso Maria de' Liguori
§. 2. Si confutano le tre opinioni secondo le quali difendono i materialisti che la materia può pensare.
15. La prima opinione fu di Epicuro, il quale disse che la virtù di pensare sta annessa alla materia, e nasce dalle sue diverse affezioni, cioè dalla sua grandezza, figura, sito e moto. La seconda opinione è di Hobbes, il quale scrisse che il pensare nasce solamente dal moto delle particelle materiali. La terza opinione fu di Stratone (come portano) il quale disse che il pensare è una virtù insita naturalmente nella materia.
16. La prima opinione di Epicuro, che il cogitare dipende dalle diverse affezioni di figura, di sito ecc., è chiaramente falsa; perché tali affezioni non possono mai mutar la natura della materia. Se il sito, la figura ed il moto inducessero la cogitazione nella materia, farebbero che il tutto avesse diversa natura dalle sue parti, le quali confessa Epicuro non aver forza di pensare. La natura del tutto che è l'unione delle parti, non può esser differente dalla natura delle parti; altrimenti basterebbe dividere un corpo, o fargli mutar figura o sito per fargli mutar natura. Sicché volendo gli epicurei far nascere la cogitazione da quelle affezioni, vogliono farla nascere dal niente e senza causa efficiente; mentre le affezioni naturali della materia non sono né possono esser altro che la stessa materia.
17. Parimente falsa è la seconda opinione di Hobbes, che il pensiero nasce solamente dal moto della materia. Ma che mai ha che fare l'idea del moto coll'idea del pensiero? Il moto non può cagionar altro che la divisione o l'aumentazione, o pure la diversa situazione della materia; ma come queste cose possono formare la cogitazione? Se poi i moti della materia fossero pensieri, ogni nuovo moto cagionerebbe nuovo pensiero, anzi sarebbe lo stesso pensiero: cosa che lo stesso Hobbes nega.
18. Ma udiamo nel di lui sistema come mai si formi il pensiero dal moto della materia. Ecco com'egli lo spiega: Causa sensionis est externum corpus, quod premit organum proprium, et premendo efficit motum introrsum ad cerebrum, et inde ad cor; unde nascitur cordis conatus liberantis se a pressione per motum tendentem extrorsum (che è quel moto chiamato da lui reazione) qui motus apparet tanquam aliquid externum; alque apparitionem hanc, sive phantasma vocamus sensionem, cioè cogitationem; così l'intende Hobbes nel suo Leviathan, cap. I. Ma questo ognuno lo vede che non è parlar da filosofo, ma da pazzo. E pure oggidì questo, o simile a questo è il filosofare alla moda che fin nella nostra Italia si è intruso, ed ha rovinati tanti poveri giovani, che, desiderosi di acquistare nuove cognizioni, e amanti di libertà, essendo spinti dal bollor giovanile, a fin di menare una vita più tranquilla ed esente dai timori, come dicono, della gente pregiudicata, facilmente s'inducono a credere queste inezie, o pure a dubitar delle verità della fede; e così si abbandonano poi a' vizj, vantandosi del nome infame dispiriti forti, e disprezzano religione, Dio e tutto. Oh miseria! Iddio gli ha creati a similitudine di se stesso, ed essi studiano per rendersi simili alle bestie.
19. Ma veniamo al punto. Se i moti di tali particelle fossero pensieri, o cagionassero il pensiero, tutti i pensieri nascerebbero in noi necessariamente da ogni moto di tali parti e tutti a caso e senza consiglio; sicché non vi sarebbe più in noi né libertà di pensare, né sapienza né previdenza del futuro; le quali cose all'incontro noi sperimentiamo in noi stessi che sono di nostra elezione.
20. Di più le ricordanze che noi spesso abbiamo sulle cose passate, e le riflessioni che sopra di quelle facciamo, sono in noi per momenti, come vediamo; mentre ci ricordiamo di tanti fatti avvenuti da molto tempo, e sopra quelli ci fermiamo a riflettere. Ma se queste riflessioni non fossero altro che moti della materia, cioè del nostro cervello e sangue e fantasmi che riceviamo dagli oggetti esterni, il soggetto della cogitazione non sarebbe più permanente, ma passaggiero, siccome è passaggiero il moto della materia; sicché non potremmo più riflettere sulle nostre percezioni, né averne più memoria. Per averne memoria dovrebbe dirsi che quella percezione avrebbe da trasferirsi per più anni successivamente, con mantenersi sempre fermo il suo sistema delle particelle; altrimenti, mutandosi quella figura, svanirebbe la percezione e la memoria di quella.
21. Chi volesse poi ricorrere all'opinione de' peripatetici, i quali dicono che gli oggetti materiali mandano in noi certi fantasmi di materia tenue e sottile, e che questi per mezzo de' pori s'insinuano al cerebro, e fanno nascere il pensiero, terrebbe per altro un'opinione che oggi è riprovata da tutti i moderni. Del resto gli stessi peripatetici dicono tutti assolutamente che l'anima è sempre quella che pensa, non già la materia o sia il cerebro.
22. La terza opinione finalmente di Stratone, che la virtù di cogitare è insita nella stessa materia, che per sé è cogitante, è più falsa ed insussistente delle altre. La ragione è, come già dicemmo di sopra, che nella materia non possiamo noi considerare altre qualità, che di estensione, divisione, mobilità e figura, ma non già di percezione o pensiero. Se il pensiero appartenesse all'essenza della materia, come dicono gli stratonici, ogni parte di materia, siccome contiene in sé la sua estensione e la sua figura, conterrebbe ancora il pensiero; in modo che ogni parte del nostro corpo avrebbe facoltà di pensare, e penserebbe. Ma chi mai può figurarsi questa inezia così grande?
23. La cogitazione ripugna per se stessa alla natura della materia, ch'è una sostanza composta di diverse particelle separabili tra loro e distinte; ma la cogitazione non è divisibile, perché non è composta di parti, ma tutta semplice ed individua; giacché l'uomo nello stesso istante senza successione di tempo, con un solo atto, pensando alle cose, or giudica di quelle, or ne disegna altre, or prevede le future. Ora tali pensieri non possono esser composti di più parti, poiché, se per esempio la virtù di pensare consistesse nell'unione delle parti A B C, quella virtù o sarebbe in ciascuna delle parti o nella cognizione di quelle: non può essere in ciascuna parte; perché la qualità materiale individua della parte A non può essere individua della parte B, mentre ciascuna parte di materia ha la sua propria natura individuale, e la qualità individuale d'una parte, non può esser qualità individuale d'un'altra; sicché, essendo elleno di diversa natura individuale, non formerebbero un solo pensiero, ma tanti pensieri, quant'elle sono. Neppure può consistere la virtù di cogitare nell'unione di più parti; perché, come si è detto di sopra, la qualità naturale di qualche tutto non può esser diversa dalla qualità delle sue parti, poiché il tutto differirebbe da se stesso; ond'è che se le parti non fossero estese, non potrebbe essere esteso il tutto; e se le parti non potessero muoversi, neppure il tutto potrebbe aver moto. E perciò, se le parti non han virtù di pensare, stando elle separate, per ragion che quella virtù starebbe divisa tra le parti, neppure il tutto può pensare.
Iscriviti a:
Post (Atom)